
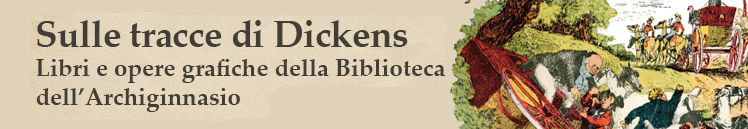
Il centro della città |
||||||
|
|
||||||
| «C'è un che di serio e di dotto in città, ed una piacevole penombra su tutto ciò, che lascerebbe un ricordo distinto e separato, tra la folla di altre città». | ||||||
| Dickens coglie un'atmosfera
«seria e dotta» in omaggio alla tradizione di Bologna
come antica sede degli studi, ma la città durante la Restaurazione
pontificia attraversa un periodo di crisi economica e anche la fama
della sua Università è in declino. Lo scrittore inglese come altri viaggiatori dell’epoca percepiscono l’immagine di una città medievale «fosca e turrita», pittoresca perché, anche senza possedere vere e proprie rovine, è al tempo stesso antica e decadente, priva di rinnovamenti urbanistici o architettonici di rilievo, e con la maggior parte dei palazzi degradati da trasformazioni operate nel corso dei secoli. Bisognerà aspettare l'unità d'Italia per vedere l'avvio dei restauri che daranno maggior decoro alla piazza e al centro cittadino. |
||||||
|
|
||||||
|
Nicolas Chapuy dis., Auguste Mathieu lit., [1846-1851] |
Veduta della Piazza del Nettuno |
|
||||
|
|
||||||
|
«Non c’è,
probabilmente, un quadro famoso o una statua in tutta Italia, che
non potrebbe tranquillamente essere sepolta sotto una montagna di
carta stampata dedicata a dissertazioni su di essa. Io per ciò,
sebbene ardente ammiratore della scultura e della pittura, non mi
diffonderò a scrivere di quadri e di statue celebri». |
||||||
|
|
||||||
|
Tito Azzolini dis., Gaspari lit. |
«Questo
libro è reso quanto più accessibile ho potuto, perché
sarebbe per me un gran piacere se io potessi sperare, per mezzo suo,
di comparare le impressioni con quelle di alcuni della moltitudine
che visiterà in avvenire i luoghi descritti con interesse e
diletto».
Le vivaci pagine dickensiane raccolgono le emozioni
dello scrittore-viaggiatore, espresse dapprima in lettere inviate
agli amici e poi raccolte nelle Pictures from Italy (1846).
Lo stile ha un taglio giornalistico e ci dipinge un quadro della
città vista cogli occhi curiosi, e talvolta critici, del
viaggiatore d’oltralpe. Lo scrittore in conformità con
il gusto artistico del suo tempo, ammira l’arte neoclassica
e ha in odio il barocco. |
|||||


