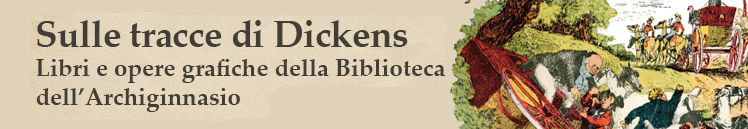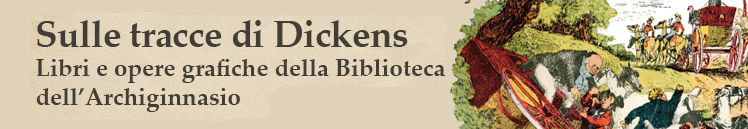|

G. B. Bordiga, Italia postale al 1/2.000000 del terreno coll’indicazione
del confine dello Stato pontificio..., 1820Partito
da Genova il 6 novembre 1844, Charles Dickens fa tappa ad Alessandria
e viaggiando tutta notte il 7 raggiunge il piccolo centro di Stradella
e vi pernotta. Viaggia a bordo di una carrozza «il
cui abitacolo sarebbe stato piccolo per un calessino»,
con alcuni tipi umani, che descrive, da par suo, con tratti arguti:
il Bravo Corriere Roche, incaricato di organizzare per lui gli aspetti
pratici del viaggio; un prete molto vecchio accompagnato da un giovane
gesuita, un avvocato di provincia e «un
signore con un naso rosso che aveva una lucentezza particolare».
A Piacenza, che era a quattro o cinque ore di viaggio da Stradella
(velocità di crociera, quattro miglia all’ora suppergiù),
arriva l’8 novembre; dorme in un albergo. Il mattino successivo
sale «sulla più alta carrozza
di posta mai vista» che lo condurrà nelle
altre città dell’Emilia, attraverso la pianura padana,
di cui apprezza l’aspetto e in particolare i vigneti ‘maritati’
agli olmi.
Il 9 visita Parma e Modena, giungendo a Bologna nel cuore della
notte. Vi resta soltanto una mezza giornata, giusto il tempo per
un’occhiata al centro storico e per una visita al Cimitero
monumentale: dopo pranzo, domenica 10 novembre riprende la diligenza
e al tramonto già esplora Ferrara. L’indomani riparte
all’alba: a tarda notte è a Venezia.
Dunque, non più di quattro giorni per attraversare l’Emilia.
La descrive con accenti di personalissima introspezione, catturato
dall’atmosfera di inerte apatia che gli suggerisce il malgoverno
nei vari stati preunitari, e in particolare nello Stato Pontificio
(«le chiavi arrugginite di Pietro»).
Con acuta lungimiranza, percepisce tuttavia le capacità di
riscatto degli Italiani (diede poi un attivo contributo alla causa
dell'indipendenza), e nel congedarsi da loro afferma: «il
buono che è sempre stato in loro è ancora in loro,
ed un grande popolo può, un giorno, sorgere da queste ceneri.
Lasciateci nutrire questa speranza!». Come preda
dell’apatia che lo circonda, il romanziere si crogiola in un
torpido ozio non senza un sottile compiacimento: «sento
che mi sto arrugginendo» afferma. «Che
strano dormiveglia, deliziosamente triste, è il vagare per
questi posti che si sono addormentati e che si scaldano al sole!
Ciascuna, a sua volta, sembra essere, di tutte le città desolate,
ammuffite, dimenticate da Dio nel vasto mondo, la capitale».
Dichiara quindi a chiare lettere il suo gusto per il pittoresco,
che le città emiliane compiutamente appagano, con la loro
decadenza avvolta da suggestive penombre. Ma va oltre, si addentra
nelle spire dell’inconscio visionario dove albergano trasfigurazioni
oniriche simbolicamente allusive, che paiono tratte dai romanzi
orrifici del suo tempo, sulla scia di Edgar Allan Poe.
E i fantasmi sono evocati, sia di fronte alla putredine del Teatro
Farnese a Parma, che Dickens trova molto adatto ad eventuali, spettrali
recite; sia nel «mostruoso»
Castello Estense, che l’alba tinge di un color rosso sangue
quasi a ricordo del supplizio inflitto a Parisina Malatesta ed al
suo amante.
Nelle descrizioni dickensiane, talvolta, gli elementi del paesaggio
negli esterni e negli interni, si animano di vita propria, disegnano
un mondo fantastico dotato di autonome inclinazioni, che riflettono
quelle del riguardante. A Piacenza «strade
di austere case … guardano in cagnesco le case di rimpetto».
Nei campi ammira «le reti gettate dalle fate sui grandi alberi
per farli prigionieri, per gioco». «Dentro
gli alberghi – osserva a Ferrara –
malevoli corridoi circondano le camere da letto da tutti i lati,
riempiendole di porte inutili, che non possono essere chiuse, che
non si aprono e che fanno capo ad un’oscurità color
della pece». Anziché nel Bel Paese sembra
spesso di ritrovarsi nei pressi della casa degli Usher, cui era
intitolato il racconto del terrore pubblicato da Poe nel 1839.
Un altro leit-motiv ricorrente è l’idiosincrasia per
la religione cattolica, vista come iterazione di riti svuotati di
ogni slancio spirituale.
|
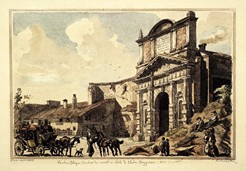
Pietro Pietra, Vecchia Bologna. Cambio dei cavalli a Porta di Strada Maggiore. 800. Sec. XX, prima metÓ.
|
|
Durante il suo secondo viaggio in Italia, proveniente
da Firenze e diretto a Venezia, tra il 20 e il 25 novembre
1853 Dickens fu di nuovo a Bologna; ma, secondo quanto scrive
in una lettera, si fermò giusto il tempo per sorbire
un tè, forse presso una delle porte della città,
dove le carrozze di posta sostavano per il cambio dei cavalli.
Pietro Pietra ha rappresentato in una serie di litografie
tratte da acquerelli policromi queste diligenze cariche di
passeggeri, ferme sotto le mura in corrispondenza dei varchi
cittadini negli anni ’30 dell’Ottocento.
|
|