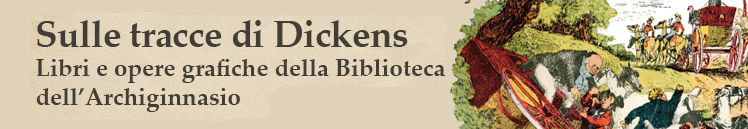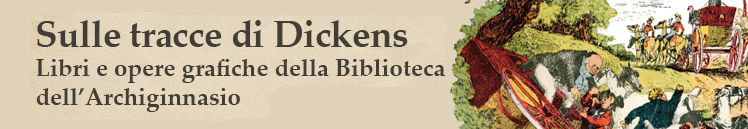|
|
Il cimitero di Bologna
|
|
Comunque
sia la domenica successiva mi sono trovato a passeggiare nel
piacevole cimitero di Bologna, tra colonnati e tombe imponenti,
in compagnia di una folla di contadini e scortato da un piccolo
cicerone locale, che aveva eccessivamente a cuore la reputazione
del posto ed era troppo sollecito a distogliere la mia attenzione
dai monumenti brutti: mentre non si stancava mai di esaltare
quelli belli».
Ciò che più distingue Bologna, oltre all’inusitato
svettare delle due torri e la Meridiana di San Petronio, è
il convento della Certosa, adibito dal 1801 a Cimitero monumentale,
unico nel suo genere in Italia, fino alla metà dell’Ottocento,
e oltre. In occasione dell’annuale apertura generale, quella
domenica 10 novembre 1844, Dickens trascorre gran parte della
mezza giornata dedicata a Bologna in questa vera e propria cittadella
dei morti affollata di turisti, in cui si aggirano anche vividi,
bizzarri abitatori che monopolizzano il suo interesse. Fra chiostri
e tombe, questi si esprimono con curiose e a tratti inquietanti
modalità: come contagiato dai suoi vicini sottoterra,
appare il piccolo cicerone, che ha piuttosto l’apparenza
e il linguaggio di un becchino: «era
un omino di carattere allegro, che sembrava non avesse in faccia
altro che occhi e denti scintillanti». Egli
intrattiene Dickens con disinvolte allusioni ai suoi lutti,
che presentano tuttavia risvolti assai macabri:
«ci sono cinque dei miei bambini
seppelliti laggiù, Signore; proprio là; un po’
sulla destra. Bene! Sia lodato il signore! Quant’è
ridente! Quant’è verde! Quant’è fresco!
E’ proprio un prato!». E
lo spietato rigoglio della natura ci appare ancor più
mortifero delle lastre tombali. Del resto questo padre sui
generis a buon diritto si rallegrava per la ridente sepoltura
concessa gratuitamente ai suoi morticini al centro del Chiostro
III o della Cappella: il Comune bolognese provvedeva così
ai defunti poveri, a differenza di quanto avveniva altrove (a
Londra, ad esempio) per i cadaveri dei diseredati gettati senza
decoro alcuno nelle fosse comuni.

Guardiani del Cimitero di Bologna davanti all’ingresso
del Cimitero, fine sec. XIXAl piccolo cicerone delle Impressioni italiane
si contrappone, con funzione di presenza rassicurante, il funzionario
comunale in divisa, nel quale è stato di recente identificato
il “Custode dimostratore” Marcellino Simbaud, realmente
esistito. Una fotografia della fine del secolo XIX ritrae i
custodi del cimitero vestiti ancora alla foggia antica.
«C’era un ufficiale così
elegante in servizio al Cimitero di Bologna dove il piccolo
cicerone aveva seppellito i suoi bambini … io guardai incredulo
il suo cappello a lucerna, i guanti di pelle di camoscio, l’uniforme
ben tagliata e i bottoni ben lucidati … Sembra che il suo
compito fosse indicare i monumenti funebri alla gente …
non aveva alcuna andatura … non più di una tartaruga.
Sostava quando la gente sostava … ed esplicitamente permetteva,
di tanto in tanto, di leggere le iscrizioni delle tombe». |
|

Emilio Anriot, Bologna. Veduta esterna
di porta Saragozza |
|
Da Porta Saragozza parte il percorso che già dall’epoca
in cui Dickens fu a Bologna conduce alla Certosa: giunti all’Arco
del Meloncello, ai piedi della salita di San Luca si imbocca
a destra il porticato lungo più di 700 metri ideato
da Ercole Gasparini e realizzato tra il 1811 e il 1834 per
congiungere agevolmente la città al suo Cimitero monumentale,
saldandosi a quello diretto alla Basilica di San Luca. Impossibile
però sapere se nella mezza giornata che lo scrittore
dedicò alla visita della città si fosse servito
di quella strada, come fece nel 1838 il giornalista e romanziere
francese Jules Janin; o se avesse raggiunto il Cimitero monumentale
lungo la via Sant’Isaia, percorsa a cavallo nel 1819
da George Byron, l’unica praticabile a quel tempo. Essa
conduceva all’imponente cancello d’ingresso del
Chiostro Quinto sormontato dalle statue dei due Piangoloni
realizzati dallo scultore Giovanni Putti nel 1809.
|
| |
|

Emilio Anriot, Bologna. Arco del Meloncello |
|
Jules Janin (Voyage en Italie, Parigi, Bourdin,
1839) descrive dettagliatamente la passeggiata da Porta Saragozza
al cimitero monumentale lungo il portico di San Luca, fino
all’Arco del Meloncello, e poi ancora lungo il braccio
di portico completato nel 1834, soltanto quattro anni prima
del suo passaggio a Bologna. Il cantiere del portico, aperto
sotto la direzione di Ercole Gasparini nel 1811, subì
in corso d’opera alcune modifiche ad opera di Luigi Marchesini
e Giuseppe Tubertini.
Racconta Janin: «Sotto
questi portici senza fine guizzano come ombre, anziché
camminare, coloro che ne sono gli abitanti. Il vostro occhio
spaventato si sofferma brevemente sugli ammassi di mura, ove
si scorgono tracce di colori sbiaditi dal turbine, vi voltate
indietro di tratto in tratto e poco a poco non so quale istinto
funebre vi spinge a sapere dove mai si fermeranno quegli archi,
ed a quale rovina, quale abisso, a quale nulla essi possano
far capo. Andate sempre così, diritto diritto, al riparo
del sole, e quando avete fatto tre miglia e percorso settecento
archi, siete giunto».
|
| |
|
 |
|
Anriot coglie una veduta della Certosa dall’ingresso
del Chiostro Quinto o Maggiore: riproduce quindi (ma più
da vicino) la stessa prospettiva proposta dieci anni prima
da Giuseppe Ravegnani nella litografia che fu pubblicata nell’Albo
a memoria dell'augusta presenza di Nostro Signore Pio IX in
Bologna (1858).
|
| Emilio Anriot, Bologna. Cimitero Comunale
già Convento dei Certosini |
|
|
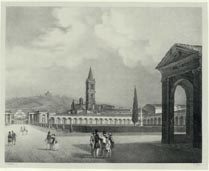 |
|
 |
|
 |
|
Giuseppe Ravegnani, Veduta della Certosa
di Bologna dall’interno
La veduta della Certosa dal Chiostro Quinto
o Maggiore fu ripresa dieci anni dopo in una fotografia scattata
da Anriot, con un’inquadratura più ravvicinata
rispetto alla Cappella Maggiore visibile sullo sfondo.
|
|
Gaetano Ferri dis., Giuseppe Rosaspina inc.,
Campo colla grande Cappella nel Cimitero comunale di Bologna
Al centro di questo Chiostro, detto della Cappella
(ora Chiostro Terzo) venivano sepolti i bambini poveri sotto
i sette anni di età, divisi tra maschi e femmine, senza
pietre tombali, ma ricoperti da un prato. Gli adulti poveri
erano invece sepolti al centro del Chiostro Quinto o Maggiore.
|
|
Luigi Basoli e Francesco Basoli inc., Antonio
Basoli dip., Cappella del Cimitero Comunale di Bologna,
1831
La Cappella dei Suffragi, che si apriva
nel Chiostro Terzo del Cimitero, fu parzialmente demolita
negli anni Sessanta dell’Ottocento; il rimaneggiamento,
ad opera di Antonio Zannoni, la ridusse a semplice atrio della
Galleria degli Angeli.
|
|
 |
|
 |
|
 |
| Petronio Rizzi, Monumenta inlustriora
Coemeterii bononiensis |
|
Petronio Rizzi, Monumento funebre di
Luigi Sampieri e Maria Vincenza De Gregori |
|
Giovanni Magazzari dis., Antonio Verico
inc., Portico che mostra il campo comune mortuario, 1828
|
|
Nei vividi acquerelli del pittore ornatista
Petronio Ricci (o Rizzi), anch’egli attivo nelle tombe
affrescate del cimitero, si trovano i disegni dei monumenti
realizzati, in via di realizzazione o anche solo ideati tra
il 1801 e il 1813. I monumenti dipinti sono ora molto deperiti,
ma risultano comunque in gran parte ancora leggibili e attendono
un restauro che si fa sempre più urgente. I disegni
del Rizzi ne mostrano l’antico splendore.
|
|
Si tratta di uno dei monumenti funebri affrescati
all’inizio del secolo XIX lungo il porticato del Chiostro
Terzo. L’ideazione e l’esecuzione si devono a Pelagio
Palagi (1775-1860).
|
|
In questo campo venivano sepolti gli adulti
di umile condizione che non potevano permettersi una sepoltura
a pagamento.
|
|
|

Gaetano Francesco Pizzoli dis., Giuseppe Rosaspina inc., Piccolo
Chiostro d’ingresso Partic. e : al Cimitero, 1828
|
|
|
|
|