|
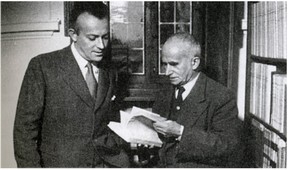
Giulio Einaudi con il padre Luigi Einaudi
nel 1951 Giulio Einaudi
nacque il 2 gennaio 1912 a Dogliani, in provincia di Cuneo,
da Luigi, economista e secondo presidente della Repubblica
Italiana, e Ida Pellegrini. La sua formazione ebbe luogo presso
il ginnasioliceo Massimo D’Azeglio di Torino, dove fu allievo
di Umberto Cosmo, Zino Zini e Augusto Monti, noto antifascista
che fu insegnante anche di Cesare Pavese, Leone Ginzburg e
Massimo Mila. Proprio quest’ultimo, già studente universitario,
fu incaricato di dare ripetizioni di latino al giovane Giulio
e lo introdusse nella cerchia degli ex allievi del D’Azeglio,
tra i quali, oltre ai già citati Pavese e Ginzburg, figuravano
Franco Antonicelli, Giulio Carlo Argan, Norberto Bobbio, Vittorio
Foa, Ludovico Geymonat, Fernanda Pivano.
A soli ventuno anni, il 15 novembre 1933, fondò la «Giulio
Einaudi Editore», con sede a Torino al terzo piano di via
Arcivescovado 7, nello stesso palazzo che era stato la sede
del settimanale «L'Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci. Pare
che l’idea di fondare una casa editrice fosse di Leone Ginzburg,
anche se non va dimenticato l’amore per il libro, strumento
di conoscenza e al tempo stesso oggetto dotato di una propria
materialità, che Giulio aveva ereditato dal padre, grande
collezionista.

La sede dell'Einaudi in via Biancamano
a Torino La casa editrice
venne subito individuata dalla polizia fascista come ricettacolo
del gruppo torinese di «Giustizia e Libertà». Nel marzo 1934
fu arrestato Ginzburg, il 15 maggio 1935 la stessa sorte toccò
a Einaudi, Mila, Foa, Antonicelli, Bobbio, Pavese, Carlo Levi
e Luigi Salvatorelli. Dopo una breve prigionia, l'editore
fu inviato al confino.
Al rientro, nel 1936, l’attività riprese con nuovi collaboratori
come Giaime Pintor e Carlo Muscetta. L’armistizio dell’8 settembre
1943 portò scompiglio nella casa editrice e ne modificò gli
assetti. Il 1° dicembre morì Giaime Pintor, saltando su una
mina mentre cercava di raggiungere Roma per unirsi alla lotta
partigiana; Leone Ginzburg venne arrestato e morì a Regina
Coeli il 5 febbraio 1944, in seguito alle torture subite.
Giulio Einaudi in un primo momento si rifugiò in Svizzera,
poi rientrò in Italia e aderì alle brigate garibaldine in
Val d’Aosta. Nell’ottobre del 1944 si recò a Roma, dove conobbe
Palmiro Togliatti.
Dopo la fine della guerra l’editore diede un nuovo impulso
all’azienda, trasferendo la sede in via Biancamano e coinvolgendo
intellettuali del calibro di Italo Calvino, Natalia Ginzburg,
Elio Vittorini, Luciano Foà e Giulio Bollati.

Ferruccio Parri, Giulio Einaudi, Pierre
Mendès-France e Giancarlo Roscioni
La gestione dell’impresa fu sempre collegiale, anche se la
decisione finale spettava all'editore. Celeberrime furono
le riunioni del mercoledì, durante le quali venivano discusse
e scelte le opere da pubblicare, e altrettanto importanti
per la vita della casa editrice furono i ritrovi estivi a
Rhêmes – Notre Dame in Val d’Aosta, dove si programmava l'attività
editoriale per l’anno successivo.
Peculiare fu sempre l’attenzione di Giulio Einaudi per la
materialità del libro: la carta, le cuciture, le copertine,
la grafica interna, dovevano assecondare il suo gusto ricercato.
A partire dal 1945 l’editore si applicò nello sforzo di sprovincializzare
la nazione uscita dalla guerra, puntando costantemente l’attenzione
su ciò che avveniva fuori d’Italia, sia nel campo letterario
che in quello scientifico, con collane che segnarono profondamente
la cultura italiana. Nacquero così le collane “Saggi”, “I
Coralli”, “I Millenni”, e poi negli anni Cinquanta “I gettoni”
curata da Vittorini, nel 1960 la “Piccola biblioteca Einaudi”,
nel 1962 la “Nuova universale economica”. Negli anni Settanta
si puntò al grande pubblico, con “Gli struzzi” e con “Centopagine”
curata da Calvino.
Negli anni Ottanta, pur non mancando
la spinta innovatrice data da collane come “Microstorie” e
“Scrittori tradotti da scrittori”, i problemi di gestione
della casa editrice si fecero evidenti. Nel 1983 la casa editrice
passò in amministrazione controllata e nel 1987 si delineò
una nuova struttura societaria, nella quale Giulio Einaudi
mantenne la carica di presidente.
L’editore andò in pensione il 4 settembre 1997 all'età di
85 anni, dopo 64 anni di attività. Morì due anni dopo, il
5 aprile 1999, a ottantasette anni, nella sua casa di Magliano
Sabina, vicino a Roma. Fu sepolto nel cimitero di Dogliani,
dove era nato e dove aveva realizzato la famosa biblioteca.
|



